articolo
Domenico Starnone
Nessuno scrittore è un buon lettore di se stesso
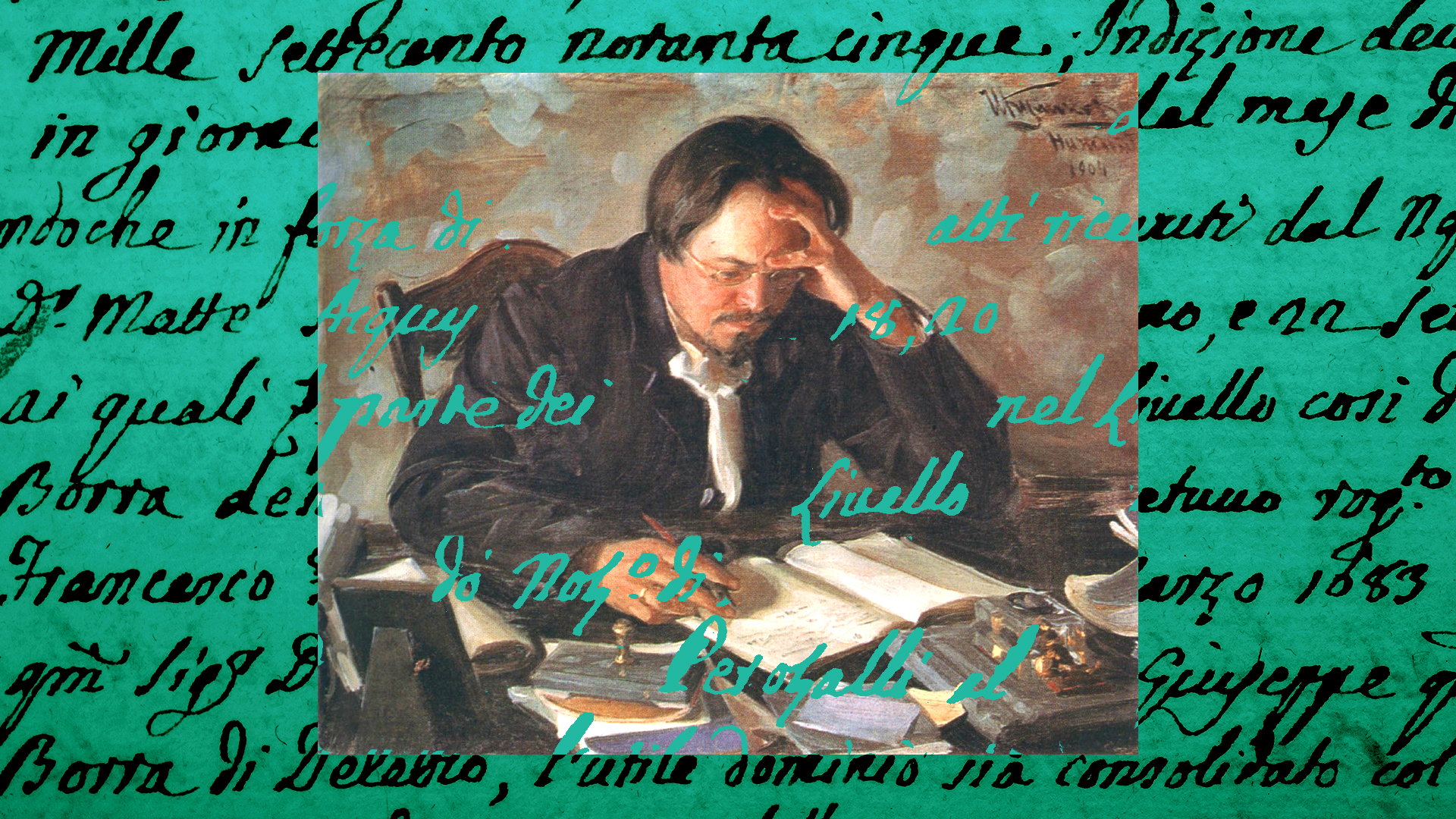
25 Luglio 2024
Tutti gli scrittori – bravissimi, bravi o così così – hanno in comune una cosa: non riusciranno mai, rileggendosi, a conoscere davvero la loro opera. Perché ciò accada, servono lettori critici e attenti: nel loro sguardo c’è la promessa di una rivelazione.
Ho sentito spesso la frase: non rileggo mai i miei libri. A volte qualcuno ammette, e io sono tra quelli: sì, se ne devo parlare in pubblico ci provo, ma con fastidio, lascio subito perdere. Per il resto, quando si cerca di andare oltre la superficie di questa riluttanza, gli scrittori svicolano. Parlano molto dei risultati della loro fatica, del piacere che hanno provato, ma fanno un’aria incerta se chiedi: ti rileggi?
La domanda li disorienta ancora di più quando, invece che ti rileggi, chiedi: ti leggi? In una mia piccola inchiesta di qualche anno fa, – roba tra amici, mi piacerebbe avere il tempo e le energie per farne una più affidabile – domandare ti rileggi risultava tutto sommato imbarazzante ma immediatamente comprensibile; passare invece a ti leggi generava attimi di perplessità, sguardi vagamente ironici, un’espressione riassumibile con: che razza di domanda è.
Pare infatti ovvio che, se scriviamo, ci leggiamo. Anzi, proprio perché scriviamo, ci leggiamo con una competenza che nessun nostro lettore potrà mai avere. Siamo – noi scrittori così così, bravi, bravissimi – i lettori più maniacalmente attenti, quelli più sensibili e profondi, delle nostre opere. Nel corso dei nostri giri promozionali rilasciamo un numero esorbitante di interviste e partecipiamo a infiniti incontri pubblici.
In quelle occasioni leggiamo qualche nostra pagina con l’intonazione più adeguata, parliamo appassionatamente dei temi che abbiamo affrontato e dei personaggi e delle vicende che abbiamo messo a punto, chiariamo come abbiamo piegato la lingua di ogni giorno al nostro personalissimo uso letterario. Ci compiaciamo insomma delle nostre opere, e non solo perché abbiamo bisogno di lettori – un libro senza lettori è una bara – ma anche perché desideriamo essere letti al modo giusto. E chi può mai essere miglior guida alla lettura, se non noi che abbiamo scritto? Il pubblico lo sa, è lì per questo.
Tutto bene dunque. Ma allora perché in linea di massima ci infastidisce rileggerci? E perché non capiamo subito la domanda: ti leggi? E perché quando la capiamo (significa: sei mai stato, di fronte alle tue pagine, nella condizione in cui si troverà il tuo lettore, quando attraverserà il tuo libro, parola dietro parola, come un territorio del tutto sconosciuto?) ci prende l’ansia?
“Siamo – noi scrittori così così, bravi, bravissimi – i lettori più maniacalmente attenti, quelli più sensibili e profondi, delle nostre opere”.
Non sono poche le occasioni in cui abbiamo pensato, ascoltando un nostro collega, che il libro – il suo libro – di cui stava parlando non era quello che noi avevamo diligentemente letto. Come non sono pochi i momenti in cui noi stessi, di punto in bianco, ci siamo sorpresi a parlare delle nostre intenzioni compositive ed espressive senza nessuna certezza che quelle intenzioni si fossero davvero realizzate sulla pagina. Allora? Ci infastidisce rileggerci perché temiamo che il libro che credevamo di aver scritto di fatto non ci sia? Ci infastidisce rileggerci perché percepiamo subito, confusamente, che in effetti non siamo stati mai nella condizione di leggerci?
Per spiegarmi provo a questo punto a ricorrere a Henry James. Mi servo di poche righe soltanto, prese da due suoi racconti, uno famosissimo, The Figure in the Carpet (1896), e uno un po’ meno famoso, The Middle Years (1893). Leggeteveli, se non l’avete già fatto. Io non mi azzardo a mettere ulteriormente bocca su quei testi, ci hanno ragionato studiosi di tutto rispetto, meglio ricorrere a loro. Dico solo che si tratta di storie di scrittori e lettori per i quali la letteratura è tutto, e aggiungo che James (1843-1916) mi pare a tutt’oggi l’autore che meglio ha raccontato cosa succede nelle teste di tutti – letterati raffinati ma anche biechi giornalisti, istitutrici pericolose, telegrafiste sognanti eccetera – quando, tra osservazione e immaginazione, proviamo a mutare la vita in racconto.
Comincio con The Middle Years, che non è solo il titolo della storia ma è anche quello dell’ultima opera del protagonista, Dencombe, uno scrittore di fama. Malato, prossimo alla fine, molto scontento del suo lungo percorso letterario, Dencombe riceve una copia di quella sua ultima fatica – forse davvero l’ultima, – fresca di stampa, e scopre che la malattia gli ha causato “uno strano distacco” (a strange alienation) da The Middle Years, un vuoto assoluto. James scrive (cito nella traduzione di Carlo Izzo):
“Non sarebbe stato capace di rimodulare a se stesso una sola frase del libro né di cercare con curiosità o con fiducia una pagina particolare. La sostanza del libro gli era completamente uscita di memoria, senza lasciarsi dietro nemmeno una predilezione”.
Sul momento lo scrittore prende male la cosa. Il libro è lì, stampato, ma Dencombe ne ha smarrito la sostanza, il testo non lo incuriosisce, non gli dà fiducia, non ne predilige nemmeno una parola. Intanto dilaga un’insoddisfazione di vecchia data, gli pare che la sua carriera sia praticamente finita, si sente un autore che ha fatto non tutto ciò che voleva ma soltanto tutto ciò che poteva. E questo scarto tra aspirazioni e capacità lo rende infelice.
Senonché comincia nervosamente a leggere e sprofonda non nel temuto vuoto assoluto ma “nel vago mondo sotterraneo della narrazione, nella grande urna smaltata dell’arte”. Il libro c’è, è di colpo tornato. E lo scrittore può constatare con soddisfazione che, se i soliti scogli (difficulties) sono sempre lì, lì nelle sue pagine c’è anche l’abilità con cui ha tentato di scansarli.

È una scoperta decisiva? No. Dencombe in sostanza è arrivato alla conclusione che ciò che non ha mai saputo fare continua a non saperlo fare, ma che parecchie cose che sa fare gli vengono sempre meglio. Niente di che, a rifletterci. Eppure quella lettura è importante e ci colpisce. Lo scrittore pare trovarsi per la prima volta nella condizione di valutare oggettivamente il proprio lavoro. E la valutazione risulta incoraggiante, tanto da generare, in bilico tra angoscia e speranza, il seguente progetto: se vivo abbastanza per scrivere ancora, irrobustirò ulteriormente la mia arte, supererò ogni difficoltà.
A questo punto sarebbe bello ragionare su come s’è letto fino a quel momento Dencombe. Perché, per esempio, ha avuto bisogno della malattia per scoprire che ha fatto buone cose e che anzi potrebbe fare ancora meglio? Non poteva riflettere sui suoi limiti e su ciò che ha imparato per evitare di sbatterci contro, anche senza la strange alienation causata dalla convalescenza?
Giriamo qualche pagina e scopriamo che quella alienazione Dencombe la va cercando da tempo con altri mezzi. James spiega:
“Dencombe era un correttore appassionato, un cesellatore dello stile; non c’era cosa la quale maturasse più lentamente di una forma, ai suoi occhi, definitiva. Il suo ideale sarebbe stato di pubblicare segretamente, e poi, sul testo stampato, sottoporsi all’atterrita revisione, sacrificando sempre la prima tiratura e cominciando, per la posterità e anche per i collezionisti, poveretti, dalla seconda”.
Soffermiamoci su questo ideale di Dencombe. Vero, verissimo, che non c’è cosa che maturi più lentamente di una forma ai nostri occhi definitiva. Ma ciò che sorprende è che questo scrittore esperto non riesca ad accontentarsi di lasciarla maturare per tutto il tempo necessario nel testo manoscritto. Sente invece il bisogno di una copia stampata da scempiare con ulteriori correzioni, e arriva a sognare di pubblicare segretamente per poi mettersi atterrito a rivedere il testo e, a lavoro compiuto, buttar via la prima edizione.
Con tutta probabilità è un modo iperbolico di cui James si serve per dire che Dencombe è tutt’altro che uno scrittore superficiale. Ma, iperbole o no, quell’ideale un po’ folle ha alla radice un’esigenza reale. Non a caso, convincersi del valore della propria arte e mettersi ossessivamente a revisionare la copia fresca di stampa di The Middle Years sono, nel racconto di James, azioni che combaciano. Dencombe probabilmente avverte che il testo stampato lo rende più vigile, e infatti non resiste a quella sorta di potenziamento dello sguardo e si mette subito a correggere, anche se la revisione non può essere che atterrita, visto che in quella concreta circostanza non c’è alcuna possibilità di rimediare buttando via la prima edizione.
Le cose oggi vanno meglio, è decisamente meno dispendioso procurarsi l’eccitante, proficua impressione di estraneità indotta da un qualche mutamento grafico. È sufficiente intervenire sul file stranoto, stralavorato, per cambiare corpo e stile dei caratteri. O, a lavoro avanzato, inviarlo alla casa editrice – io lo faccio – e chiedere di reimpaginarlo in modo da avere una perfetta anticipazione di come il libro sarà quando verrà stampato.
Be’, posso assicurare che sono trucchi che aiutano. Sul momento si ha l’impressione di leggere come se il nostro testo non fosse il nostro e potessimo finalmente vederne meriti e difetti, potenziare i meriti, correggere i difetti. Ma è un’estraneazione che dura poco, lo sguardo torna presto a non fare attrito. Cosa che probabilmente sarebbe successa anche al povero Dencombe, quando sicuramente avrebbe sentito il bisogno di altre stimolazioni degli occhi e, da infaticabile cesellatore, avrebbe presto voluto mandare al macero altre e altre edizioni. Il suo sogno di una pubblicazione segreta e quindi di una copia a stampa utile per continuare a dar forma alle intenzioni, lo avrebbe sospinto sempre più nel vicolo cieco – cieco nel vero senso della parola – in cui finisce per trovarsi di fatto chiunque scriva. È perciò forse che James non si accontenta del passaggio dal manoscritto alla stampa per sottolineare la necessità di una strange alienation, lo ritiene un segnale narrativamente insufficiente. Rielabora invece il vecchio consiglio di tenere a riposo il manoscritto per un po’ e inventa qualcosa di più radicale e di più esplicito: la dimenticanza indotta dalla malattia.
Dimenticarsi del tutto il proprio libro è infatti l’unica possibilità, per chi scrive, di leggersi come un lettore comune. E solo se Dencombe si legge come un lettore comune, come se non fosse anche colui che ha scritto, può vedere i propri risultati, ricordarsi dei fallimenti ma anche della propria arte, ambire a nuove prove, fare meglio.
Sembra tutto chiaro a questo punto. Soltanto se per assurdo perdessimo la memoria del nostro testo, potremmo sul serio leggerlo. Ma basta pescare in The Figure in the Carpet per rendersi conto che, a girare intorno a questi temi, le cose si complicano. Qui il personaggio dell’anziano scrittore di fama ha un altro nome, si chiama Vereker, ed è scontento perché, anche se i giovani studiosi della sua opera dicono un gran bene dei venti volumi che ha prodotto durante la vita, nessuno riesce a individuare “la cosa per la quale ha scritto i suoi libri”, “la cosa senza lo sforzo per ottenere la quale uno scrittore non scriverebbe affatto”, la cosa di cui lui stesso s’è accorto un poco alla volta, mentre il lavoro, di volume in volume, arrivava a compimento.
A differenza di Dencombe, Vereker è sicuro di sé, non ha dubbi sulla sua ottima riuscita di scrittore. Quella cosa, per lui è lì, concreta. Non è occultata come un segreto, se ne sta ben visibile in ogni testo, in ogni rigo o parola. È, per dirla tutta, il disegno senza il quale i suoi libri non varrebbero un fico secco. E tuttavia i suoi affezionatissimi lettori, anche i più esperti, non la vedono. Lo scontento di Vereker deriva quindi dal fatto che ciò che lui è sicuro di aver scritto, il lettore, fosse pure il più sensibile, non riesce a leggerlo.
Ed è proprio un suo giovane recensore di talento a cercare di venire a capo della questione con una domanda semplice e chiara, qui nella traduzione di Massimo Ferraris: Sarebbe in grado, penna alla mano, di definirla chiaramente questa cosa? Darle un nome, esprimerla, formularla?
Vereker risponde in modo elusivo. Sospira: “Oh, se soltanto fossi, penna alla mano, uno di voi ragazzi”. Che significa: certo che sarei capace, se fossi al posto di voi giovani recensori. Ma significa anche: poiché non sono al posto vostro, non sono capace. L’interlocutore di Vereker percepisce entrambi i significati e la conversazione procede così:
“Sarebbe una grande occasione per lei, naturalmente. Ma perché disprezzare noi ragazzi perché non facciamo qualcosa che lei stesso non è capace di fare?”.
“Non sono capace di fare? (…) Non l’ho forse fatto in venti volumi? Lo faccio a modo mio, mentre voi non lo fate nel vostro”.
“Il nostro è maledettamente difficile” (…) .
“Anche il mio. Ognuno sceglie il suo. Non c’è nessuna costrizione (…) ”.
In sintesi Vereker ha detto quattro cose interessanti: a) se fossi un critico sarei capace di fare quello che voi dovreste fare e invece non fate; b) che io sia capace di fare quello che voi non siete capaci di fare l’ho dimostrato in venti volumi; c) il guaio è che sono capace di farlo a modo mio, mentre voi non siete capaci di farlo a modo vostro; d) il mio modo è scrivere, il vostro è leggere: entrambi i modi sono difficili, ognuno scelga il suo e sgobbi.
“Ci infastidisce rileggerci perché temiamo che il libro che credevamo di aver scritto di fatto non ci sia? Ci infastidisce rileggerci perché percepiamo subito, confusamente, che in effetti non siamo stati mai nella condizione di leggerci?”
Vereker non viene mai sfiorato dal dubbio che la cosa che passa di volume in volume, e che ha faticosamente scoperto scrivendo, potrebbe lui stesso non essere in grado di individuarla leggendo. Anzi butta lì la vanteria che, se fosse un giovane critico, ce la farebbe. Ma poi qualcosa cede e l’anziano scrittore traccia una linea netta di separazione tra scrivere e leggere. In sostanza dice al suo recensore: io la cosa posso cercarla e nominarla soltanto al mio modo, facendo letteratura; tu invece la puoi cercare e nominare solo al tuo modo, facendo lettura critica. Se non sei capace mi generi infelicità, mi lasci con l’ansia che nessuno individuerà mai ciò che fa dei miei venti volumi una grande opera. Peggio ancora: il tuo fallimento potrebbe indurmi a pensare che ho confuso le intenzioni col risultato e che le mie opere non valgono un fico secco.
Torniamo al punto di partenza. Sospetto da tempo che noi scrittori – bravi, bravissimi e così così – non sappiamo cosa ci sia veramente nei nostri libri. Ne parliamo, ci affanniamo a spiegare come siamo arrivati al cuore pulsante delle nostre opere, inventiamo formule che ben sintetizzano le nostre fatiche. E qualche volta lo facciamo con tale fantasiosa intelligenza che la nostra autoanalisi è più seducente dei nostri stessi testi. Cosa che a maggior ragione ci confonde: possibile che in ciò che abbiamo scritto non ci sia quello che crediamo di aver scritto, possibile che siamo in grado di parlare soltanto delle nostre intenzioni?
Non è naturalmente un fenomeno d’oggi, gli autori si sono sempre autodefiniti. Ma negli ultimi decenni la cosa ha raggiunto proporzioni mai viste. Il moltiplicarsi delle occasioni alle quali accennavo prima, quelle in cui più o meno volentieri parliamo dei nostri libri, fa sì che ci lasciamo alle spalle un numero spropositato di interviste e registrazioni audiovisive eternamente a disposizione in rete. Al punto che non è raro sentirsi dire: caro scrittore, non ho letto nessuno dei tuoi libri ma ho visto che hai dichiarato ciò che intendevi rappresentare con quella scena in cui lui grida a lei brutte parole, sicché colgo l’occasione per chiederti eccetera eccetera. Noi in genere non ci tiriamo indietro e via a chiarire, approfondire, elucubrare non tanto sulla nostra operina ma su ciò che a proposito della nostra operino abbiamo dichiarato.
L’autocommento, l’autodefinizione sono ormai così diffusi, così facilmente reperibili, che chi a vario titolo, per obbligo o per vocazione, si mescola alla ressa odierna di noi scrittori può risparmiarsi la noia di leggere i nostri libri e la fatica di cavarne un nocciolo, limitandosi a occhieggiare, leggiucchiare ciò che ne abbiamo detto in quella circostanza e in quell’altra e muovendo da lì per incensarci o insultarci. Non solo. I lettori stracolti, i chiacchieroni estrosi, i recensori malevoli o benevoli usano a volte il nostro formulario come se lo avessero autonomamente dedotto dallo studio dei testi. La conseguenza è che spesso ciò che si legge delle nostre opere è fondato su ciò che noi stessi abbiamo divulgato, evidenziando, secondo le occasioni, le ragioni segrete e le qualità nascoste delle nostre fatiche letterarie.
Non ci sarebbe niente di male se questo ci facesse felici. Ma non ci si sente in realtà mai tanto infelici come quando leggiamo o sentiamo dire, a proposito dei nostri libri, ciò che noi stessi da qualche parte abbiamo dichiarato o scritto. Anche perché in non pochi casi ciò che diciamo o scriviamo è la sbrodolatura o la sintesi brillante di osservazioni dei nostri primi lettori: mogli, figli, amici di cui ci fidiamo. Invece ciò che ci aspettiamo, ciò che intensamente desideriamo, è una rivelazione. Vogliamo che qualcuno ci dica cosa abbiamo davvero combinato scrivendo, cosa abbiamo davvero fatto di ciò che intendevamo fare e che di opera in opera abbiamo creduto di aver realmente fatto. Perché la mia ipotesi – voglio ripeterlo adesso con chiarezza – è che, anche nei casi in cui produciamo belle formule sui nostri temi e personaggi e stile, noi non sappiamo e non possiamo leggere ciò che abbiamo scritto. Per farlo dovremmo dimenticarci della nostra scrittura, come Dencombe. O ammettere, come Vereker, che il nostro modo (la letteratura) è inevitabilmente altro da quello della lettura critica, e che i due modi vanno tenuti separati per il bene sia della letteratura che della critica. Ma la prima cosa è una trovata di narratore e la seconda non ha spazio nei tempi in cui viviamo. I due modi si sono rovesciati l’uno nell’altro a tal punto che gli scrittori si sentono gli unici veri critici e i critici si sentono gli unici veri scrittori.
Perciò non so se la matassa si può davvero sbrogliare. Scrivere e leggere stanno da sempre promiscuamente insieme in un nodo che non si scioglie. A cose fatte puoi dire: ora leggo, ora scrivo, mettendo anche qui artificialmente ordine, come facciamo sempre in ogni manifestazione della magmatica vita. Ma sotto l’ordine – letterario, scientifico – resta, male imbrigliato, il magma. Perciò tendo sempre più a sostituire, tra me e me, il verbo ‘scrivere’ con il verbo ‘vivere’, mi pare che prometta più verità.
Ho trovato quest’uso, parecchio tempo fa, nella prefazione del 1927 che Svevo scrisse per la nuova edizione di Senilità. Il passaggio è questo, corsivo mio:
“La predilezione del Larbaud per questo vecchio romanzo me lo rese subito caro come nel momento stesso in cui l’avevo vissuto. Lo sentii subito nettato da un disprezzo durato per trent’anni, cui io, per debolezza, avevo finito con l’associarmi”.
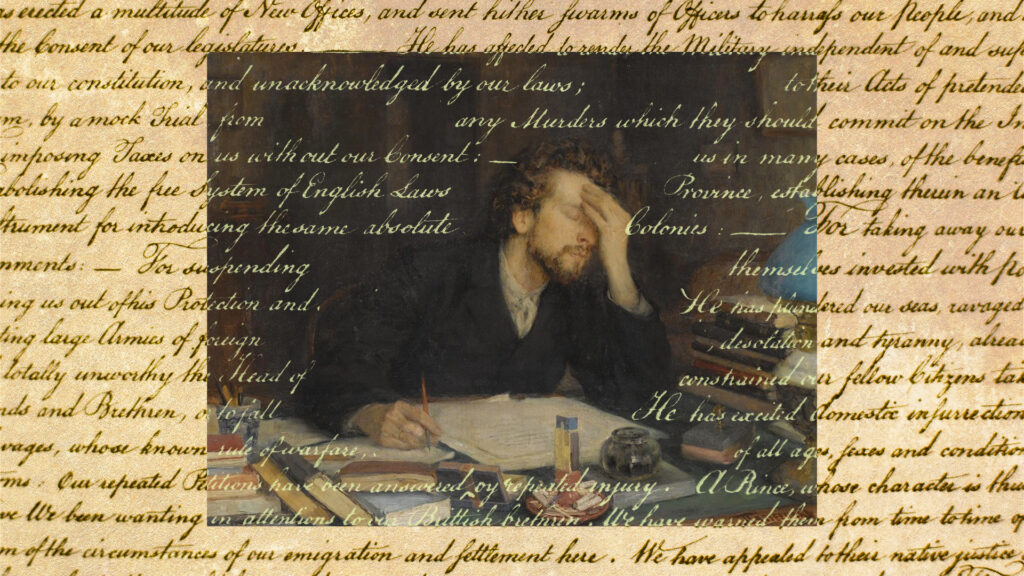
I libri – grandi, piccoli, belli, brutti – non si scrivono, si vivono, e al solito in un garbuglio di propositi, affetti, pensierini. Perciò ciò che ci finisce dentro è sfuggente, sempre, innanzitutto per chi li scrive-vive. Svevo ha caro Senilità mentre lo vive. Poi la lettura italiana, critica e non, lo ignora del tutto, lo ha in spregio. E lui, che pure lo ha avuto caro, finisce per trent’anni con l’assorbire quel disprezzo, farlo suo. Per debolezza, dice. Ma cos’è la debolezza di uno scrittore se non l’impossibilità di leggersi come se non avesse scritto, valutarsi in assoluta autonomia e trarre da quella valutazione di lettore la forza per dire: non ho bisogno di nessuno, non della cecità italiana e, di conseguenza, nemmeno della vista lunga di Valery Larbaud? Cosa che naturalmente è impensabile, se non nella forma diffusissima, specie tra letterati e artisti, della più insopportabile, ottusa presunzione. Quindi, per Svevo, la debolezza diventa forza solo nel momento in cui interviene un sostegno esterno: i francesi. È allora che, dal modo secondo cui ha vissuto trent’anni prima Senilità, recupera sentimenti positivi nei confronti del suo libro.
Insomma la possibilità di leggersi – persino di rileggersi – di uno scrittore anche grandissimo si fonda sugli occhi altrui, con tutti i rischi del caso. Non resta che augurarsi in futuro scrittori che, lavorando sodo con il loro specifico modo, si meritino lettori critici che, lavorando sodo con il loro specifico modo, se li meritino.
Domenico Starnone
Domenico Starnone è scrittore e sceneggiatore. Collabora con «Internazionale» e altre testate. Il suo ultimo romanzo è Il vecchio al mare (Einaudi, 2024).

Nessun commento:
Posta un commento